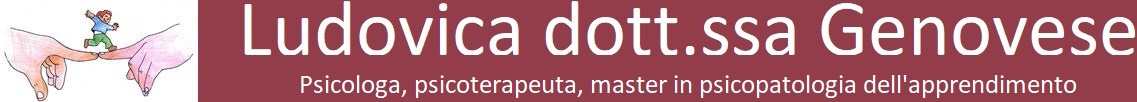Da circa 20 anni, prima in Europa e poi in Italia, si parla di insegnamento per competenze, più nelle carte degli esperti che non nella pratica quotidiana. La parola “competenze” crediamo suoni piuttosto ostica agli orecchi degli insegnanti, anche a causa del fatto che ci sono modi diversi di affrontare questo tema.
Da circa 20 anni, prima in Europa e poi in Italia, si parla di insegnamento per competenze, più nelle carte degli esperti che non nella pratica quotidiana. La parola “competenze” crediamo suoni piuttosto ostica agli orecchi degli insegnanti, anche a causa del fatto che ci sono modi diversi di affrontare questo tema.
C’è chi oppone alla scuola delle competenze la scuola delle conoscenze, c’è chi sostiene che la competenza è l’esito di un addestramento e chi invece la ritiene una conquista della persona alla fine di un processo educativo. Poiché la normativa prevede che alla fine i docenti debbano certificare le competenze acquisite, sicuramente è opportuno tentare di dare una risposta su cosa significa insegnare per competenze. Compito arduo, ma proviamoci.
Una volta esisteva la scuola delle conoscenze, a volte chiamata scuola nozionistica, insomma la scuola delle cose da imparare. Adesso, e sempre più in futuro, ci sarà la scuola delle “competenze”, dove le cose/discipline che si insegnano/imparano non avranno più un valore in se, ma avranno importanza in quanto “utilizzabili”, applicabili a situazioni concrete, insomma, in qualche modo “spendibili”. Quello che importerà non sarà più sapere, ma “saper fare”.
Al di la del merito della questione, se cioè questo sia un bene o un male per il processo educativo, questa trasformazione della scuola nasce perché l’Europa è grande e i paesi che la compongono sono diversi. Ma c’è l’esigenza di poter far valere una “misura comune”, ciò che è certificato in Italia deve valere anche per la Germania o per la Francia, al fine di permettere una trasmigrazione di studenti da un paese all’altro. Ma cosa è misurabile con certezza? Non certo il sapere “nozionistico”, sicuramente assai diverso da una nazione all’altra, bensì le “competenze”, il saper fare ed il saper imparare, i metodi e non i contenuti. Misureremo e certificheremo i cosiddetti Learning Outcomes (risultati di apprendimento) e le nostre prove INVALSI vanno sicuramente in questa direzione.
La definizione ufficiale europea di competenza recita: “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”. In pratica: capacità di “saper utilizzare” quello che si è appreso mentre al di fuori di questo, tutto il resto che si è imparato resterà lettera morta.
Una volta non ci si chiedeva se studiare la Divina Commedia di Dante o le poesie di Leopardi avrebbe avuto una “ricaduta” concreta, perché fino a qualche decennio fa, i canti di Dante avevano un fine in sé e la cultura era esattamente questo: qualcosa di assolutamente fine a se stesso, molto al di fuori di un possibile risvolto “commerciale”. E’ fin troppo facile ricordare, a tal proposito, dove troviamo questo spirito di sapere per il gusto di sapere. Ci ricorda infatti Aristotele:
“Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli altri astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando già c'era pressoché tutto ciò che necessitava alla vita ed anche all'agiatezza ed al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. E' evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa.” E ancora:
”Tutte le altre scienze saranno più necessarie di questa (della metafisica), ma nessuna sarà superiore.” (Metafisica, I,2,982b).
Il pensiero geometrico, prima dei greci, era fondato quasi esclusivamente dalla necessità di risolvere problemi concreti. Per gli egizi, per esempio, una linea retta, in modo del tutto letterale, era una corda tesa o una linea tracciata nella sabbia. Un rettangolo era un recinto che limitava un campo. Ma è solo con i semi derivanti dall’astrazione matematica operata da Euclide che l’uomo occidentale ha potuto raggiungere certe conquiste tecnologiche.
Noi, e con noi l’Europa, ci stiamo avviando verso un cammino contrario a questo spirito. Porterà un progresso di civiltà questo cambiamento?
Si badi bene che non ci si chiedeva se serviva studiare Dante o Foscolo ai Licei, ma negli Istituti Tecnici-Commerciali e Professionali. E non ce lo si chiedeva perché si sapeva con certezza che comunque, in qualche modo, Dante o Leopardi sarebbero serviti al perito o al ragioniere. Tenendo presente infatti che la scuola dovrebbe formare innanzitutto un buon cittadino e, in subordine, possibilmente anche un buon perito o geometra, si dava per scontato che un sapere in se produceva un bene all’individuo, lo rendeva migliore come cittadino e poi come lavoratore. Ci si sbagliava?
Potrà apparire incredibile, ma la parola scuola, che per la massima parte dei giovani suona come lavoro, sudore, pena, sonno perduto, ansie e, qualche tempo fa, a volte scapaccioni, in origine significava esattamente il contrario: Il Il termine scuola deriva dalla parola latina schola, derivato a sua volta dal greco antico σχολεῖον (scholeion), da σχολή (scholḗ). Il termine greco significava inizialmente "tempo libero", per poi evolversi: da "tempo libero" è passato a descrivere il "luogo in cui veniva speso il tempo libero", cioè il luogo in cui si tenevano discussioni filosofiche o scientifiche durante il tempo libero, per poi descrivere il "luogo di lettura", fino a descrivere il luogo d'istruzione per eccellenza. (da Wikipedia).
Riconquistare un po’ di questo spirito antico, ossia una scuola come “esercizio di libertà” sarebbe auspicabile. Filosofia sterile? Forse. Quel che temiamo, invece, è che la scuola delle competenze darà un colpo mortale a tutto ciò che ancora resta di culturale e speculativo nelle nostre scuole superiori, rendendo minimale tutto quello che riguarda un sapere astratto e “inutile”, in nome di qualcosa subito spendibile e professionalizzante. Quali saranno le conseguenze di questo ce lo dirà un futuro non troppo lontano.