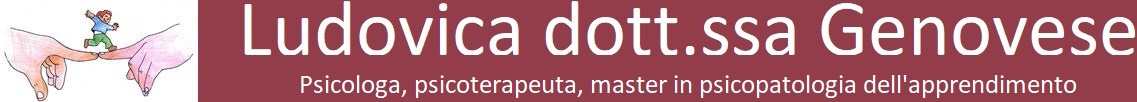Parte prima: il mito
 Quando un aspetto della realtà emerge in modo inedito, sorprendente e anche doloroso, ci mancano le parole per definirlo, cioè dargli confini. Farlo ci aiuta a identificare il mostro e a confinarlo in un territorio circoscritto e meno pauroso.
Quando un aspetto della realtà emerge in modo inedito, sorprendente e anche doloroso, ci mancano le parole per definirlo, cioè dargli confini. Farlo ci aiuta a identificare il mostro e a confinarlo in un territorio circoscritto e meno pauroso.
La definizione “nativi digitali” è uno di quei neologismi fortunati per confinare un mostro di ben altra entità. Confinato il mostro nel recinto tecnologico, ci sembra di poterlo gestire meglio o quanto meno di non subirne l’ombra minacciosa.
Ma andiamo con ordine.
“Nativi digitali” è efficace metafora che indica coloro che sono nati in uno spazio (il nativo è l’aborigeno, l’autoctono) fatto di tecnologia digitale, rispetto a coloro che vi arrivano provenendo da un altro spazio: coloni, immigranti. L’altra faccia del nativo digitale è quindi il “colono digitale” che sbarca nell’isola del nativo e ne rimane abbagliato e confuso allo stesso tempo. La generazione dei nativi digitali infatti provoca sudori freddi a quella dei coloni, che si sono ritrovati ad usare una tecnologia nuova e vi si sono adattati (in alcuni casi, anche volentieri).
Ma lavorare quotidianamente con i nativi digitali mi ha fatto capire che si tratta di un mito, una narrazione con cui nascondiamo un altro mostro. Lo dico perché i nativi mi sembrano tanto imbranati quanto la generazione precedente. Nell’uso generico di smartphone, social, pc sono rapidissimi, ma in fin dei conti raggiungono un livello simile a quello di un adulto normale. Ma quando si tratta di operazioni più complesse chiedono aiuto e, soprattutto, non si chiedono mai cosa ci sta “dietro le quinte”. In tal senso, i cosiddetti smanettoni sono molto rari. La stragrande maggioranza sono semplici fruitori, a volte anche squilibrati. Insomma, il nativo digitale non ha un cervello nuovo o diverso da quello degli adolescenti della mia generazione. E la scienza lo conferma.
L’inventore del termine non è uno scienziato ma (c’era da aspettarselo) uno scrittore e designer di videogiochi di apprendimento. Si chiama Marc Prensky e nel 2001 si è inventato il nesso “digital natives, digital immigrants” riferendosi a chi impara a parlare una lingua sin da bambino, un madrelingua digitale, per distinguerlo da chi ne ha appreso l’uso in modo non naturale. Secondo Prensky questa lingua madre digitale ha modificato il cervello dei nativi, che apprendono in modo diverso dai loro predecessori, motivo per cui la scuola non tecnologica e digitale risulta loro incomprensibile e noiosa. Una semplificazione che chi sta a scuola sa di non poter accettare.
Questo mito è diventato presto efficace proprio per la sua semplificazione. Ha dato una scusa ad adulti che non riescono più a farsi ascoltare e vedono la noia dipinta sui volti dei ragazzi: “ha un altro cervello, non può capire, non è colpa mia, altri tempi”. Dico una scusa perché in realtà si evita il vero problema: l’inceppamento, la frattura di dialogo che si è creato tra generazioni. Ha inoltre fatto salire sul carrozzone della scuola i profeti della tecnologia, convinti che lavagne elettroniche e tablet avrebbero risvegliato i cervelli addormentati dal professore analogico (che in dotazione ha solo “la parola”). Invece non siamo di fronte ad un nuovo tipo di homo sapiens, non c’è una generazione diversa dalle precedenti, né una mutazione genetica. L’unica differenza che è stata scientificamente dimostrata non è tra nativi e coloni, ma tra utilizzatori e non utilizzatori degli strumenti. Il cervello si specializza in breve tempo grazie ad azioni ripetute, ma questo, in relazione alla tecnologia, si dà ad ogni età e non solo nei giovanissimi. La plasticità del cervello è ben altra cosa da una mutazione genetica. Non c’è un solo studio scientifico che dimostri che il cervello dei ragazzi sia mutato, anzi gli studi operati per verificare hanno dimostrato il contrario: il cervello non muta in una generazione; le tecnologie attivano aree cerebrali che ognuno di noi attiva quando realizza compiti diversi dall’abituale (come imparare una lingua nuova) e che quindi sono attivazioni di scopo e non mutazioni strutturali; le tecnologie non determinano la motivazione che manca allo studente per ben altri motivi.
Pertanto, non è riducendo la Divina Commedia in tweet da 140 caratteri inviati da Dante Alighieri a renderla interessante per un sedicenne. La tecnologia senz’altro ci potrà affiancare ed aiutare a raggiungere quella che erroneamente chiamiamo “attenzione” dei ragazzi, ma che in realtà non è altro che il loro “stato di veglia”. Quindi la tecnologia (dalla lavagna al tablet) resta quello che è sempre stato: un grande alleato per afferrare lo stato di veglia e incanalarlo verso l’attenzione. Ma l’attenzione resta compito nostro, compito dei docenti e degli educatori, dotati della tecnologia eterna della “parola” e di un grande amore e passione per la professione che, si spera, si sono scelti di fare nella loro vita lavorativa.